L’Opinione di Mauro Enrico Pè
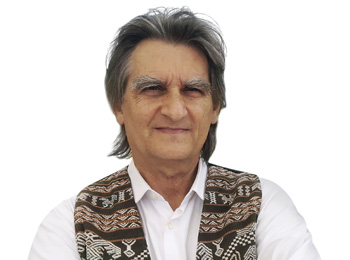 In un annus horribilis come il 2020, con effetti drammatici sulla vita di tutti noi e con gravi ripercussioni sulla tenuta del sistema agroalimentare nazionale e mondiale, uno squarcio di luce e di ottimismo proviene dal Comitato per il Nobel. Nell’arco di pochi giorni sono stati attribuiti due premi che, in modo quasi complementare, hanno una valenza particolare per l’agricoltura dell’immediato futuro.
In un annus horribilis come il 2020, con effetti drammatici sulla vita di tutti noi e con gravi ripercussioni sulla tenuta del sistema agroalimentare nazionale e mondiale, uno squarcio di luce e di ottimismo proviene dal Comitato per il Nobel. Nell’arco di pochi giorni sono stati attribuiti due premi che, in modo quasi complementare, hanno una valenza particolare per l’agricoltura dell’immediato futuro.
Il premio Nobel per la Chimica è stato conferito a Emmanuelle Charpentier, francese, e a Jennifer A. Doudna, statunitense, due ricercatrici che con le loro scoperte hanno, nelle parole del Comitato, «sviluppato un metodo di genome editing», espressione che richiama l’analogia con il processo di revisione di un testo scritto, nel caso specifico la sequenza di DNA.
Il metodo del genome editing può essere esemplificato con l’immagine di un paio di forbici molecolari che, sempre dal comunicato del Comitato Nobel, «consentono di modificare il DNA di animali, piante e microrganismi con una precisione estremamente alta».
In breve tempo il genome editing sta già avendo un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita. Il premio Nobel a Charpentier e Dudna ci offre un ulteriore spunto di riflessione, ovvero come non ci possa essere avanzamento tecnologico senza la conoscenza scientifica ottenuta dalla ricerca di base. L’eccessiva enfasi data alla ricerca applicata a scapito della ricerca di base alla lunga è controproducente.
La Società italiana di genetica agraria (Siga) ha avuto già modo di sottolineare sulle pagine de L’Informatore Agrario l’enorme potenzialità applicativa di questa scoperta sulla produzione di nuove varietà che abbiano caratteristiche funzionali a un’agricoltura produttiva, sempre più sostenibile, di elevata qualità e adeguata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle eccellenza del made in Italy.
È importante ribadire che le modificazioni apportate con il genome editing sono equivalenti a quelle prodotte naturalmente dai processi di mutazione spontanea, che forniscono la variabilità genetica sulla quale agisce l’evoluzione, e per questo motivo la Siga, supportata da altre società scientifiche, ha proposto di definire il genome editing una delle «Tecnologie di Evoluzione Assistita», TEA.
Noi siamo convinti che le TEA, insieme alla rivoluzione digitale, siano i pilastri sui quali progettare e realizzare l’agricoltura dell’immediato futuro, agricoltura che non può prescindere dall’essere produttiva, anche nelle condizioni determinate dai cambiamenti climatici.
Questo punto trova un aggancio solido con il Premio Nobel per la Pace, assegnato al World food programme, agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma. La motivazione richiama «lo sforzo di Wfp di contrasto alla fame, il contributo al miglioramento delle condizioni di pace in aree soggette a conflitto, agli sforzi diretti a prevenire l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto».
Esattamente 50 anni fa lo stesso Nobel per la Pace fu assegnato a Norman Borlaug, genetista agrario e artefice della rivoluzione verde, il quale affermò che «per aver la pace è necessario produrre più cibo». Ancora oggi si stima che circa 690 milioni di persone soffrano la fame, la maggior parte residenti in aree di conflitti, e che tale numero aumenterà a causa della pandemia di Covid-19.
In Europa si sta giocando una partita cruciale per svincolare le TEA e i loro prodotti dalla regolamentazione estremamente restrittiva sugli ogm, ai quali sono equiparate. È necessaria una convinta e forte alleanza tra ricercatori, produttori agricoli e consumatori. Servono investimenti in ricerca, azioni di trasferimento tecnologico e di comunicazione a operatori e consumatori, affinché l’Europa e l’Italia non siano escluse da questa rivoluzione e per lanciare quindi una nuova rivoluzione verde, che permetta un’intensificazione sostenibile delle produzioni, utilizzando tutti gli strumenti disponibili per «produrre di più con meno» mantenendo la tipicità che ci caratterizza.
Mauro Enrico Pè
presidente Società italiana di genetica agraria



